“Quarto giorno” è una silloge di Marcello Comitini in cui il lettore può trovare i propri riscontri nella complessa, ricca immagine dell’esistenza che non attinge alla linea incorporea, impersonale della dimostrazione, ma alla riflessione che si nutre di sapori o della realtà intuitiva del vissuto. E’ un’opera di profonda umanità naturale, che arriva a forme di forte realismo, di attenzione alla realtà contemporanea, sorretta e spinta verticalmente da una tensione morale sempre attiva caratterizzata da un’incisione critica ed etica del reale, da un racconto bruciante nelle dolenze e nelle rivendicazioni del presente.
Il valore della scrittura poetica di Comitini sta nella capacità di leggere il mondo con emozione e disinganno, con soprassalti di umore e generosa adesione critica, e di renderci l’insieme di queste sue varie e variabili sensazioni nell’esattezza di una lingua e di uno stile sempre in equilibrio.
In questi testi possiamo perderci negli scioglimenti di un percorso che, attraverso riferimenti al simbolismo di un verso tra la sensualità e l’oscurità di un sentire mai sazio, e desideri di mitologie e disincarnazioni fuggiasche ed epiche, si risolve in una meditazione sulla figura dell’Uomo come indagatore a cui però non è data conoscenza ma servizio. La vita è inseguita, bramata, perseguita entro le tracce di un desiderio che ha nello smarrimento, nel suo rischio, l’indice di una umanità ancor viva (come le buganvillee dell’omonima poesia) pur nelle secche degli sradicamenti. Ed è poesia di carnalità, di una libertà vezzeggiata e carezzata grazie anche a un uso ricco e attento di una parola piena, densa per riconoscimento e prossimità con gli uomini e le cose, di un dettato autentico, di una scrittura che si riflette nella natura per descrivere la condizione umana: “Le farfalle sono la nostra speranza e la nostra
contemporanea invidia. Posseggono tutto ciò che noi non possediamo:
colori, agilità, libertà leggerezza (anche spirituale)
e il piacere di vivere intensamente
la loro breve vita.” (pag.12)
Quella di Comitini non è una poesia della fuga, no, ma di una presenza forte all’interno dei chiaroscuri di un’esistenza che svapora, che non si dice e non ci dice se non per scarti che possono però anche essere preziosi, nell’incantesimo di un irraggiungibile culmine. Per tale motivo questo dettato risulta essere caro, perché prossimo e riconoscibile nelle sue consonanze, e vivo proprio in quel linguaggio ricco di suggestioni, grazie al quale sa incarnare evocazioni e ritorni di un’anima affaticata, ferita e dolente ma malinconicamente mai vinta.
Un testo ricco, intenso e mai banale, un dettato estremamente fisico ispirato dall’alternanza, soprattutto mentale, delle stagioni, in quel contrasto d’anime sospinto tra le pieghe di estati ed inverni che andiamo a subire tra promesse inevase ed ormai lontane di luce e gelo, di gioco di luci e penombre. Nel caso particolare, se c’è un testo ripensato a lungo nella coscienza, sottratto al dato immediato di emozione e di natura, questa è la prosa poetica dell’autore che avvicina queste pagine alla vivezza del parlato, alla intenzionalità di un particolare: come nel parlato la scrittura si distende fluida ma ha anche la secchezza del giudizio, non immune da qualche variazione di tono e di lingua. I colori presenti, che partecipano non tanto ai dati empirici quanto alle dinamiche del linguaggio, sono lampi di rosso (accostato al sangue, al colore delle foglie in autunno, al vino lasciato nei calici), sono colori metallici, freddi e taglienti come lame, più spesso il colore della poesia è l’azzurro purgatoriale del tempo, dei misteri elegiaci della memoria e la tonalità più scura che appartiene non tanto alla radiosità del mattino quanto alla profondità dell’acqua e della notte. Lo spazio profondo ha questo colore, che poi diventa anche quello del tempo. Si può sottolineare, in alcuni momenti dell’opera, la colorazione pesante del grigio (l’afa, il silenzio, la severa concentrazione di un interno, il deserto polveroso di chi ha perduto tutto: “Cosa posso fare io cantore e cieco?//Trascino le mie ali lungo il mio deserto//di polvere e di gesso” (pag 49), la “nebbia dell’illusione”). Tutto ciò ha una rispondenza nei testi di Comitini: nella luce, spesso senza connessione, che c’è nella coscienza e nello “sguardo” della sua parola, noi sentiamo un venir meno di luce, di colori e un forte richiamo carnale.
Al termine di questo libro, al lettore resta l’impressione di un versificare segnato da antiche ferite alle quali dare, nel lenimento metafisico di una parola che rinominando ricuce e annulla distanze, spazio di lettura e incontri di mondi nuovi. Non terreni però, giacché per l’autore il nostro è un luogo chiuso, se non di morte comunque di reclusione e di annullamento. Così, se in apparenza l’anima si muove sempre rivolta al cielo (a spazi siderei che, per eccesso di astrazione, sono poco comunicati) è il ventre nero della memoria e del suolo a pronunciarsi cruentemente, a bussare senza inviti tra le maglie di un quotidiano stonato, privo d’ordine, nel segno di una maligna storia infinita. E, di più, nella ricerca di un’armonia che venendo dalla lingua possa liberare varchi è piuttosto la nota, la sillaba rimossa ad imporsi con forza con rigurgiti ed esiti poeticamente validi per autenticità di dettato dolorosamente e urgentemente incalzanti. Forse, anche oltre le sue stesse intenzioni, perché questa è una poesia del freddo: freddo e distanza da una vita che non ha che vani impacci e separazioni, e silenzi da proporre e a cui rispondere; ma freddo anche come bene prezioso che tiene all’erta, contro le illusioni del caldo e dei suoi falsi conforti là dove si celano parole e angosce mute. Perché sono infatti i ricordi dolorosi che la ragione e la parola tentano, insieme, di chiarire e di tacere a consentire al verso di restare sfidando e opponendosi allo strappo che ci attende (nell’incisivo concetto di chiamare amore le fratture) e a quella morte che consente solo una breve sosta e un’uscita dall’ombra (come l’”uomo o un bambino musulmano o cristiano//vergine o incinta, che siano poveri o ricchi,//atei comunisti fascisti” che giacciono tra vetri e lamiere, o i corpi sbattuti dalle onde sugli scogli o la donna uccisa dal femminicida). La morte, già…, davvero inaccettabile, così quasi come la vita perché compressa in un tempo per noi non eterno e addomesticabile solo rendendolo vuoto e diretto verso uno stacco fra la terra e l’ignoto.
Dunque, secondo Comitini, siamo senza speranza? Certo che no, “perché sentiamo in realtà dentro di noi che la vita è dura//ma è sempre vita che ci farà aprire gli occhi ancora domani e ritroveremo tutto il nostro mondo, le nostre abitudini,//i nostri tanto desiderati e deprecati affetti.”
(Luisa Debenedetti)

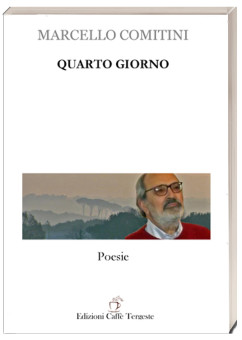
dunque, quarto giorno dovrebbe essere, se non sbaglio, giovedì….